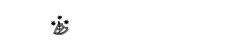La festa di San Giovanni, nel Sud, è un rito proletario. È l’estate celebrata alla fine di giugno, mese traboccante d’amore giallo paglierino. Si racconta che le ragazze, là dietro ai fuochi d’artificio, si fanno tirare su le gonne dai ragazzotti rinvigoriti dalla primavera. Che le signorine ricevano «l’eucarestia» quella notte è possibile, ma che se ne tragga una moda sessuale o una sorta di sacrificale tipico delle religioni primitive, è davvero una sorpresa. Nel Sud, la festa di San Giovanni è un pretesto per caramelle, una fantasia con sudore obbligato, un ballo popolare con cornetta in si bemolle.
Lo conoscevo bene il cornettista; si chiamava Camaro. O meglio, non lo conoscevo ancora, perché non stavo lì. Voglio dire… non per tutti. Al prossimo anno, mio bel cornettista di orribili polke! Mia madre mi terrà in braccio e sarà fiera, e vi saluterà, Monsieur Camaro, e voi gonfierete le guance, respirerete profondo e sputerete la lingua in quel bocchino ridicolo.
Eravamo alla fine di giugno del 1914 e io sarei nato nel mese di agosto.
Mia madre, Sophie Misère, aveva una passione per il lavoro da sarta. Molto più di una inclinazione: un destino, un mestiere represso, irrealizzato, un violino d’Ingres 2 grosso come un contrabbasso. Lo si sapeva nel quartiere e lei era diventata suo malgrado un’autorità in materia. Venivano a trovarla con deferenza, l’occhio appeso alle sue labbra: «Dite, Sophie, credete che quest’orlo sia abbastanza alto? Ho letto che andava più corto quest’anno. Che ne pensate?».
E mia madre parlava, la falangetta dell’indice sui denti superiori in un andirivieni che indicava in lei la determinazione, l’altra mano sull’anca come un atleta mancino, gli occhi saputi e impareggiabili nell’infilare l’ago, tutto questo ritmato da un ballo di San Vito in relazione diretta con il sistema urinario per il vezzo di fare pipì all’ultimo istante. Quella ritenzione era per lei, immagino, una fonte di godimento, soprattutto durante le conversazioni. La vescica strillava, lei la calmava danzando.
«Non è l’orlo a fare la moda, mia cara. Su un orlo ci si può sempre accordare. Bisogna lavorare sul taglio, sul drappeggio. La moda del resto si fa con carta e matita. È anzitutto un disegno, uno schema.»
Aveva attinto questo lessico a una prima di Patou che veniva, una volta l’anno, a gustare gli scampi a casa nostra in cambio di modelli ultraleggeri. Mia madre li studiava la notte come piani diabolici. Ho sempre ammirato quei modelli di carta. Per lei, erano una preda da scuoiare. C’è chi gioca a baccarà, mia madre giocava con i modelli. Era il suo vizio privato.
«Lasciamelo, il vestito. Vedrò che poterne fare.»
E l’altra se ne andava tutta contenta. Mia madre aveva diagnosticato, adesso le toccava curare il tessuto gualcito e inventare una forma nuova all’abito smesso dell’amica. Con le sue dita da fata, i suoi occhi da gufo e le sue nottate perpetue, mia madre faceva la moda nel quartiere.
«Sophie! Attenta al bambino!»
Ci si occupò così di me la prima volta. Mia madre, molto chic, in abito di ampiezza calcolata che ingannava gli sguardi più avidi e smaliziati, ballava con un amico di famiglia. Io, causa involontaria di quella ampiezza, raggomitolato in quella terra degli uomini che è fatta di sangue e di effemeridi rigorose, già indisposto dalla polka sputata da Monsieur Camaro, sgambettavo e le significavo i miei umori da futuro melomane. Mio padre stava all’erta sulla sua donna e sul proprio seme. Non approvava che mia madre ballasse, incinta di sette mesi, e la sorvegliava come si fa con una giumenta.
«Si muove, Pierre! Oh, su! non gli fa mica male!»
E continuava più forte, presentendo che non sarebbe tornata a ballare tanto presto, perché un’altra danza stava per cominciare, con i suoi passi di morte, i suoi salti di terrore incrociati e il suo valzer di miseria.
Fu l’ultima festa di San Giovanni. Ne sarebbe scorso di sangue da qualche parte prima che Monsieur Camaro attaccasse di nuovo con il suo ignobile strumento, la cornetta, figlia illegittima della tromba. Se ne sarebbero abbattuti, da qualche parte, di strani bersagli animati prima che Pierre Misère, mio padre, impugnasse la carabina sotto gli occhi dell’acetilene e colpisse, paf!, il cerchio centrale del bersaglio. Se ne sarebbero sentiti di galli cantare nelle albe putride e stinte prima che mia madre, Sophie Buonanima Misère, tra due polke, arrivasse a far girare la ruota della fortuna e riportasse a casa un galletto stupito, buono per la pignatta. Dirò ai cuochi ignoranti che la pignatta, al mio paese, è la pentola.